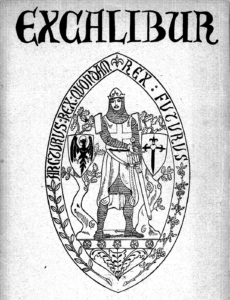
Rivista trimestrale di storia delle religioni ed etnosociologia dell’Istituto Romano per la Ricerca Interdisciplinare (Anno I, Gennaio-Marzo 1977)
*****
Preambolo della Redazione
Inauguriamo oggi la ripubblicazione di alcuni articoli già proposti, diversi anni or sono, nella storica rivista Excalibur.
Essa si distinse per l’approfondimento di temi di carattere ‘tradizionale’, offerti ad un pubblico soprattutto giovanile con l’esplicito intento di combattere le innumerevoli confusioni che già a quell’epoca ne caratterizzavano le coscienze.
Con l’obiettivo di porre in chiaro e correggere gli stravolgimenti a cui il significato di Tradizione veniva sottoposto, gli argomenti ivi affrontati intendevano proporre la struttura stessa del pensiero tradizionale: in primo luogo i principi, quindi la loro applicazione a livello spirituale, poi i conseguenti sviluppi sul piano civile e culturale.
La trattazione del giusto concetto di “sacro”, sempre più negletto e mortificato nel contesto della moderna e profana società, dava modo oltretutto di porre in luce l’allontanamento della tradizione cattolica dalla sua radice vitale, auspicandone il suo più sollecito ed integrale recupero.
La presente riproposizione di alcuni tra quegli scritti, che più si pongono nella linea del sito Regina Equitum, non vuole assolvere ad una finalità meramente storico-rievocativa, quanto piuttosto rispondere alla constatazione che molte tra quelle confusioni a tutt’oggi non paiono esser state purtroppo ancora risolte.
*****
Pochi argomenti sono oggi così male conosciuti e inestricabilmente confusi con idee sbagliate e preconcette come tutto ciò che riguarda la figura del Cavaliere cioè che cosa sia e in quale modo lo si diventi. E a questo fenomeno, per quanto ciò possa stupire, non fanno eccezione neanche gli stessi ambienti dove la Cavalleria dovrebbe essere l’unica ragione di vita, né gli ambienti dove alcuni cattolici coraggiosi e pur preparati conducono una valorosa battaglia contro il noto “fumo di Satana”.
Intanto facciamo una premessa indispensabile: è ovvio che noi non ci occuperemo in questa sede degli Ordini cavallereschi intesi come onorificenze, decorazioni, ecc. Il nostro esclusivo interesse è rivolto alla Cavalleria come via di perfezione spirituale e come missione di redenzione del mondo da parte degli uomini a ciò chiamati e qualificati.
Definita in questo modo l’essenza della Cavalleria, è evidente l’assurdità della semplicistica identificazione fra il Cavaliere e qualunque combattente a cavallo. Mentre il Cavaliere all’atto dell’Investitura s’impegnava ad una conversio morum e diveniva un “consacrato”, il guerriero a cavallo era tenuto solo alla fedeltà al suo signore ed era semplicemente un combattente specializzato, come diremmo oggi; questa distinzione era tenuta presente nel latino medioevale dalla presenza dei due termini: miles, per il Cavaliere propriamente detto, ed eques per il combattente a cavallo, distinzione che si è mantenuta anche in alcune lingue moderne anglosassoni come l’inglese e il tedesco, ma si è persa invece nelle lingue neolatine, per cui noi usiamo il termine Cavaliere per entrambi i significati.
Passiamo ora alla parte più intricata della matassa e cerchiamo di sbrogliarla: il punto chiave che permette di illuminare il problema è l’Investitura. Due concetti devono essere ben chiari per poter proseguire senza difficoltà:
1) l’Investitura cavalleresca può essere conferita solo da un Vescovo, o un Abate, o da un Cavaliere che sia stato a sua volta già regolarmente investito;
2) l’Investitura cavalleresca è un sacramentale, e, più precisamente, una consacrazione o benedizione costitutiva, sia nel caso dell’Investitura liturgica (quella conferita da un Vescovo o da un Abate) che di quella laica (quella conferita da un Cavaliere).
E ora ci scusiamo con il lettore per la lunghezza della citazione, ma ci sembra indispensabile, per la comprensione del problema, riportare quanto affermato dall’Enciclopedia Cattolica (edizione del 1953 – vol. X) alla voce “sacramentali”: «Secondo il C.I.C. (Codex Juris Canonici) i sacramentali non implicano soltanto una separazione delle cose dall’uso profano e pertanto una certa santità legale, ma importano pure l’impetrazione di qualche effetto spirituale. […] Come i sacramenti, i sacramentali consistono in qualche cosa di sensibile, sono dotati di un’efficacia superiore a quella delle buone opere dei privati, e infine ottengono effetti spirituali. […] La differenza fra consacrazioni e benedizioni consiste nel fatto che le consacrazioni hanno sempre per effetto di separare in modo stabile un oggetto o una persona dall’uso profano, […] nelle benedizioni, invece, si usano solo le parole, e soltanto le benedizioni costitutive, a differenza di quelle semplicemente invocative, comportano una separazione stabile dall’uso profano. […] L’efficacia dei sacramentali, in quanto deriva dall’impetrazione della Chiesa, non dipende come da causa dalle disposizioni morali del ministro o del soggetto. Pertanto si dice che i sacramentali non agiscono ex opere operantis ministri vel subiecti, e in ciò convengono con i sacramenti; da essi però differiscono perché l’efficacia di questi è ex opere operato. Si può porre la questione se oltre a quest’efficacia, fondata sull’intercessione della Chiesa, i sacramentali non ne posseggano un’altra ex opere operato. Il C.I.C. non ne fa menzione. Parecchi autori (per esempio il Michel, Théologie Catholique, Paris 1909, XIV-465-82) l’affermano a proposito di quei sacramentali che hanno per effetto di dedicare cose o persone al servizio divino; infatti, il rito esterno obiettivamente preso e compiuto secondo le norme prescritte quando il soggetto non oppone impedimento, produce l’effetto di consacrare la cosa o la persona al servizio divino. […] Il C.I.C. parla in genere di effetti specialmente spirituali. La maggior parte degli autori li distribuisce nelle seguenti categorie:
- a) grazie attuali che eccitano a compiere atti di fede, di speranza, di carità, di penitenza, ecc.;
- b) allontanamento o repressione del demonio;
- c) beni temporali, come la salute, il tempo buono, sempre però nella misura in cui conducano alla salvezza eterna e rientrino nel piano della provvidenza ordinaria di Dio».
In quanto rito l’Investitura cavalleresca possiede elementi che sono fondamentali ed altri accessori: gli elementi fondamentali sono lo schiaffo (militaris alapa), la spada con cui si batte di piatto sulle spalle o sulla testa del neo-Cavaliere, e la cintura o cingolo con cui lo si cinge (cingulo militari).
Senza questi elementi presenti nel rito non si è Cavalieri, neanche se si fosse membri professi di una religione militare!
Presenti questi elementi, l’Investitura è un sacramentale ugualmente valido sia nel caso dell’Investitura laica che di quella liturgica; infatti non può essere ripetuta come dimostrano i rituali di alcune religioni militari che, all’atto dell’ammissione di un nuovo fratello, prescrivono di domandare se egli sia già stato investito Cavaliere, nel quale caso si passa direttamente alla semplice professione religiosa.
Dal rituale dell’Ordine di Malta:
«Le Chevalier: Que demandez-vous? »
«Le Profès: l’Ordre de Chevalerie».
«Le Chevalier: L’avez-vous jamais reçu de prince catholique ou autre qui eut puissance le pouvoir donner?»
Alcuni pontificali adottano anche la formula dubitativa nel caso dell’investitura:
«…si non esto miles…»
Questa equivalenza fra Investitura liturgica e laica è sempre stata universalmente riconosciuta dalla Chiesa e mai posta in discussione ed è paragonata alla consacrazione Reale e a quella degli Abati e a questo titolo ricevette, come le altre due, l’appellativo di “ottavo sacramento”.
Un’altra distinzione, che era ben netta all’uomo della civiltà cristiana, era quella tra Cavalleria onorifica e Cavalleria sacramentale.
Basti ricordare l’episodio storico di Francesco I re di Francia (e come tale già Cavaliere e Gran Maestro degli Ordini della Corona) che, volendo essere veramente Cavaliere, nel senso più alto del termine, si fece investire, lui Re, da Baiardo, semplice Cavaliere, ma effettivo, il quale come tale era depositario di un potere che neanche ai Re era concesso, ma solo ai Cavalieri e ai Vescovi. Gli stessi Re dunque non si consideravano realmente Cavalieri se non dopo essersi inginocchiati davanti a un altro Cavaliere, magari loro suddito, per ricevere regolarmente l’Investitura.
E con questo possiamo affrontare l’ultima causa di continue confusioni: quella riguardante i membri delle religioni militari che vengono comunemente chiamati indistintamente tutti “Cavalieri”.
Il rito di ammissione deve consistere, per i motivi che abbiamo appena visto, di due parti ben distinte: l’Investitura e la professione religiosa: gli antichi Ordini militari non contavano solo Cavalieri, anzi questi erano una piccola minoranza, circa uno su dieci, rispetto all’insieme dei vari combattenti a cavallo, ausiliari, impiegati nei vari servizi, cappellani e membri “terziari”. Tutti costoro potevano essere membri professi o conversi o novizi o terziari, ma anche se professi non per questo erano Cavalieri.
La professione e l’imposizione dell’abito completo o del solo mantello o dello scapolare è il rito dell’ammissione in un determinato Ordine cavalleresco, non dell’ordinazione cavalleresca.
Facendo un esempio, un uomo che avesse fatto la professione solenne nell’Ordine del Tempio sarebbe stato sì un Templare professo, ma non per questo un Cavaliere Templare, se non era già Cavaliere da prima, magari facendosi investire da chi comandava la commanderia locale.
I documenti storici che confermano questo modo di procedere sono innumerevoli; ci limitiamo, tanto per dare un esempio, a citare la deposizione di Guichard de Marchant, siniscalco di Tolosa, al processo dei Templari in cui racconta come investì e fece entrare nell’Ordine del Tempio un suo parente, Ugo di Marchant: «Messere Ugo di Marchant, della diocesi di Lione, che era mio parente e aveva studiato a lungo diritto, fu ricevuto verso i quaranta anni, per mio intervento, nel Tempio di Tolosa: proprio quel giorno io lo feci Cavaliere, intendo dire Cavaliere laico, nella grande sala della commanderia; dopo di che i fratelli lo ricevettero nella camera che era vicino alla sala».
Identico uso presso gli Ospedalieri di San Giovanni, come dichiara la regola originale: «Nul en l’ospital ne requierge estre frère-Chevalier, ne li a esté promis (avant qu’il reçeust l’habit de la Maison de l’Ospital, mesmement quand il sera de tant de eage) qu’il peust estre Chevalier au siècle».
Gli “stabilimenta di Ulm” (1496) prescrivono ugualmente: «Chiunque domanda l’ammissione alla professione del nostro Ordine deve essere necessariamente investito prima di ricevere l’abito e di fare la professione».
Quest’ultimo testo è particolarmente interessante, perché distingue molto chiaramente i tre momenti che vengono così spesso confusi:
a) l’investitura per cui si diventa Cavalieri (laici o religiosi, membri di un Ordine a qualunque titolo o come professi);
b) la ricezione nell’Ordine (come novizio, o come terziario);
c) la professione (l’appartenenza totale e permanente ad un Ordine).
Il rapporto Investitura-professione in un Ordine militare è esattamente parallelo a quello ordinazione sacerdotale-professione in un Ordine religioso.
Pensiamo che adesso sia chiaro che l’Investitura cavalleresca e la professione religiosa rappresentano due momenti nettamente distinti. L’Investitura è comune a tutti i Cavalieri, sia laici che religiosi, e la professione è comune a tutti i religiosi, militari e no.
Con questo abbiamo voluto solo introdurre un discorso che proseguirà, nei prossimi numeri, sui metodi “propri” alla Via cavalleresca, come via di perfezionamento spirituale per gli scudieri fedeli alla via tracciata da quel Cavaliere che disse: «È giunto il momento di vendere il mantello per comprare la spada».
FRANCO ERSILLI